
La madre delle infermiere
— Francesca Granata, ricecatrice
La chiamavano “la signora con la lanterna” perché ogni notte passava tra i letti dei suoi pazienti per donare conforto. Un’azione che oggi diamo per scontata da parte di un infermiere, ma che nel 1850 non lo era affatto. Infatti Florence Nightingale è ricordata in tutto il mondo, oltre che per i suoi gesti di grande umanità, anche perché è considerata la madre delle scienze infermieristiche.
Il suo nome, se digitato nel motore di ricerca scientifico Pubmed, compare in oltre 8000 articoli. Questo perché grazie ai suoi insegnamenti di infermiera e alla formulazione della “teoria ambientale” ha rivoluzionato e migliorato il mondo della pratica clinica fino ai giorni nostri.
Florence applicò le sue teorie sul campo, durante la guerra in Crimea del 1853, tra le corsie dell’ospedale militare di Scutari. Si focalizzò sul concetto di ambiente, inteso come spazio ospedaliero in cui vive il paziente, come fattore principale nello sviluppo delle malattie. Individuò cinque fattori essenziali per aumentare la sopravvivenza dei malati, riorganizzando l’ospedale secondo questi dettami: avere aria pulita, acqua pura, un sistema fognario efficiente, pulizia, e luce. Inoltre, oltre a questi punti vitali erano importanti anche il silenzio, il calore e un'alimentazione corretta. Grazie alle sue osservazioni e alla sua capacità gestionale il tasso di mortalità nel suo reparto scese quasi del 40%.
La dedizione di Florence per l’assistenza ai malati e agli indigenti nasce assieme a lei: fin da giovanissima, infatti, si era dedicata all’aiuto del prossimo e all’età di 25 anni annunciò alla famiglia di voler dedicare l’intera vita alla cura delle persone, rinunciando ad essere moglie e madre per timore che il matrimonio la distraesse dalla sua vocazione.
All’epoca, per una donna rifiutare di avere una famiglia era un affronto alla società, che i suoi genitori inizialmente non approvarono, anche perché la professione di infermiera all’epoca non era considerata nobile. In seguito il padre, uomo di grande cultura, comprese le intuizioni della figlia e le divergenze si appianarono: così Florence, finalmente sostenuta anche dalla famiglia, abbracciò definitivamente la sua vocazione. Si trasferì, per un breve periodo nel 1850, a Dusseldorf soggiornando in un ospedale diretto da diaconesse. Il confronto con quella realtà così ben gestita le confermò ogni sua intuizione: maggiore assistenza, pulizia e cura aumentavano la sopravvivenza dei pazienti, se confrontata con le strutture ospedaliere nelle quali aveva lavorato fino ad allora. Grazie a questo confronto formulò le prime teorie che poi applicò durante l’esperienza in Crimea.
Per il ruolo fondamentale che ricoprì durante la guerra nell'assistenza ai feriti, Florence Nightingale fece ritorno in patria come un’eroina. Di lì a poco la Regina Vittoria la coinvolse nella stesura di un rapporto che stabiliva nuove regole sanitarie da applicare anche in campo civile, così che molti ospedali vennero costruiti seguendo quelle indicazioni.
La sua carriera raggiunse l'apice nel 1859 quando riuscì, grazie all’aiuto di una cospicua raccolta fondi, ad istituire la Nightingale Training School a Londra. Una scuola aperta a un massimo di 15 allieve destinate a divenire le prime infermiere e a cambiare per sempre gli ospedali inglesi ed europei. Pochi anni più tardi riuscì ad aprire anche il nuovo Royal Buckinghamshire Hospital ed il Women's Medical College.
Dalla formulazione delle prime regole igieniche che ancora oggi vengono rispettate (come la pulizia delle mani per evitare la diffusione dei virus), alla fondazione di un College, la vita di Florence ha rappresentato la salvezza per molte persone, dando la possibilità ai sopravvissuti e ai guariti di generare vita. Forse non fu madre in senso stretto ma le sue scoperte, le azioni e la dedizione l'hanno resa la madre delle scienze infermieristiche come disciplina a sé stante rispetto alla medicina.
Non è un caso se il 12 maggio di ogni anno, in suo onore, si festeggia la giornata internazionale dell’infermiere: una figura sanitaria che oggi risulta essenziale ed insostituibile, che ha dato prova di forza e tenacia anche in questi due anni di pandemia, al fianco delle persone ammalate.
Articolo tratto dal magazine Blister, storie dal Policlinico per curare l'attesa
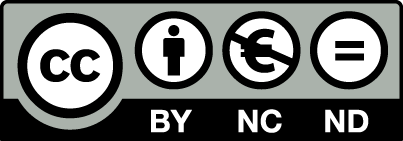


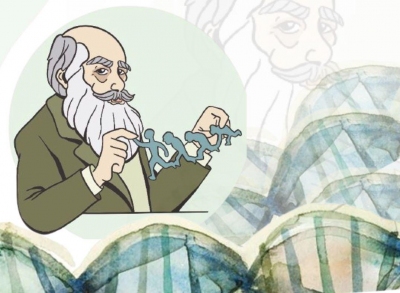

 News e consigli dagli esperti
News e consigli dagli esperti