
Mozart, un genio irrequieto
— Francesca Granata
Wolfgang Amadeus Mozart, nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi che ebbe influenze anche su altri artisti come Ludwig van Beethoven. Infatti, fin da bambino, Mozart mostrò un talento straordinario per la musica, componendo opere e suonando in pubblico già a cinque anni. La sua carriera musicale lo portò a viaggiare per l'Europa, dove impressionò le corti e il pubblico con la sua straordinaria abilità. All’età di soli 17 anni, fu assunto come musicista alla corte di Salisburgo. Tuttavia, una serie di disaccordi con il principe-arcivescovo Colloredo lo spinsero a lasciare questo prestigioso lavoro e a trasferirsi a Vienna nel 1781.
Questo trasferimento potrebbe sembrare il risultato del comportamento impertinente di un ragazzo di soli 17 anni, ma riflettendo bene, quale persona con un talento così straordinario metterebbe a repentaglio la propria reputazione e carriera? Per rispondere a questa domanda, pochi decenni fa alcuni studiosi, tra medici e psicologi, hanno iniziato ad analizzare Mozart come possibile paziente. Gli studi principali suggeriscono che gli atteggiamenti eccentrici e scontrosi di Mozart, che andavano dal linguaggio scurrile ai movimenti ripetitivi di mani e piedi e alle mimiche facciali esagerate, potrebbero non essere semplicemente parte della sua personalità, ma indicativi della sindrome di Tourette.
La sindrome di Tourette (ST) è un disturbo neurologico caratterizzato da movimenti e suoni ripetitivi e involontari, noti come tic, che possono variare in tipo, frequenza e gravità. Spesso associata a disturbi come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e il disturbo ossessivo-compulsivo (OCD), la sindrome prende il nome dal neurologo francese Georges Gilles de la Tourette, che la descrisse nel 1885, molto tempo dopo la morte di Mozart, avvenuta il 5 dicembre 1791, all'età di soli 35 anni.
Ma come hanno posto un sospetto diagnostico così complesso? Come spesso accade per molti artisti dell'epoca, sono proprio le loro lettere a lasciarci traccia delle loro condizioni psicofisiche, come nel caso di Mozart. L’analisi di queste corrispondenze ha portato nel 1985 il dottor Benjamin Simkin, un endocrinologo, pianista, musicologo e storico, a trovare prove di linguaggio eccessivamente volgare e fuori contesto in 39 delle 371 lettere, soprattutto quelle indirizzate alla cugina Maria Anna Thekla. Gli studiosi hanno esaminato non solo le lettere, ma anche le biografie scritte su di lui e le testimonianze dell'epoca per giungere a questa ipotesi diagnostica.
Un episodio tratto dal libro “The Mozart Compendium” lo descrive in uno di questi atteggiamenti “fuori dalle righe”, mentre sta improvvisando una composizione: "Ad un certo punto si stancò, si alzò in piedi e, nel folle umore che così spesso lo sopraffaceva, iniziò a saltare sopra tavoli e sedie, miagolare come un gatto e fare capriole come un ragazzo indisciplinato". Chi assisteva a questi episodi lo considerava non consapevole di quanto stesse facendo e di come da questi atteggiamenti quasi spontanei derivassero poi conseguenze sociali che lo portavano spesso in situazioni problematiche e di conflitto con le persone con le quali interagiva. Contemporanei come sua sorella Nannerl e il violinista Karl Ditters von Dittersdorf hanno documentato i suoi movimenti incessanti e i suoi gesti inconsueti, considerati dai medici storici come manifestazioni dei suoi tic motori e vocali. Una descrizione del suo fisico e comportamento recita: "Era magro e pallido; e sebbene la forma effettiva del suo viso fosse straordinaria, la sua espressione era memorabile solo per la sua estrema variabilità. I suoi tratti cambiavano da un istante all'altro, senza mai rivelare altro se non il piacere o il disagio che provava in quell'istante immediato. Aveva un tic o idiosincrasia che, di regola generale, è sintomo di stupidità: il suo corpo era perpetuamente in movimento; giocava incessantemente con le mani o batteva nervosamente sul pavimento con i piedi".
Sebbene ci siano prove che suggeriscono che Mozart potesse avere davvero la sindrome di Tourette, la questione rimane aperta e controversa. Infatti, ancora oggi è difficile fare una diagnosi differenziale, immaginiamoci senza avere il paziente di fronte come nel caso di Mozart. Il limite è che non esistono test specifici per diagnosticare questa sindrome e la diagnosi frontale con il paziente è essenziale; lo specialista di neuropsichiatria si deve basare su vari elementi. Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), i criteri per la diagnosi della sindrome di Tourette includono la presenza di tic motori e vocali, la durata dei sintomi per più di un anno, l'età di insorgenza prima dei 18 anni e l'esclusione di altre cause. La valutazione clinica richiede una storia dettagliata dei sintomi, l'osservazione dei tic e valutazioni neurologiche e psichiatriche.
La genialità musicale di Mozart resta indiscussa, così come la sua difficile esistenza segnata da alti e bassi emotivi che lo resero vulnerabile e in conflitto con la società. Stabilire il confine tra genialità e la spinta migliorativa derivante da una condizione patologica è un compito arduo, ma come dimostrato da molti artisti come Van Gogh, Beethoven e Toulouse-Lautrec, l'incontro di certe caratteristiche mentali e difficoltà fisiche può spingere la persona a superare i propri limiti, affinando l'intelletto ed esplorando mondi che fisicamente non potevano raggiungere date le loro limitazioni e condizioni. Tutti loro hanno viaggiato nella mente per creare un rifugio di serenità creativa, utilizzando l'arte come mezzo di espressione e trasformando le loro sfide in opere di valore universale.
L’enigma diagnostico di Mozart resta aperto, ma a differenza sua, i pazienti di oggi hanno accesso a un supporto diverso grazie a team multidisciplinari che utilizzano terapie farmacologiche, comportamentali e psicosociali per ottenere il miglior risultato possibile per la salute e il benessere del paziente, come avviene nel reparto di neuropsichiatria del Policlinico di Milano.
Articolo tratto dal magazine Blister, storie dal Policlinico per curare l'attesa.
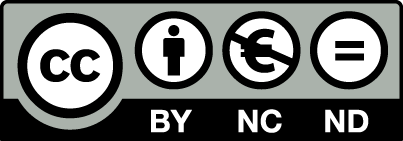


 News e consigli dagli esperti
News e consigli dagli esperti